20 nov 2009
Museo sul Brigantaggio e l'Unità d'Italia
Leggi tutto l'articolo.
19 nov 2009
Contadine... di oggi
Guarda gli scatti sexy sul sito del TGCOM.
29 ott 2009
Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana
Nella ex Gipsoteca dell’Altare della Patria, a Roma, è stato realizzato il Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana (MEI).
Percorso espositivo:
- Le origini dell'emigrazione italiana;
- L'emigrazione di massa (1876-1915);
- L'emigrazione tra le due guerre (1916-1945);
- L'emigrazione nel secondo dopoguerra (1946-1976);
- Italiani nel mondo. Mondo in Italia (dal 1977 ai giorni nostri).
2 lug 2009
Il poeta "pazzo" di Guardia

Sul sito di Repubblica è pubblicato un articolo di settembre 2007 dal titolo “Il poeta che piaceva a Natalia. Una vita tra i muri di Collegno”.
Il poeta è Felice Fischetti, nato a Guardia Lombardi nel 1931 e morto nel 2005. Nella vita è stato “carrettiere e contrabbandiere nell' Italia degli anni Quaranta, minatore in Belgio e in Francia, soldato della Legione Straniera in Algeria” ed operaio in una fabbrica della Barriera di Milano, per poi finire, a causa di disturbi mentali, nel manicomio di Collegno.
Una delle sue poesie recita così:
chi piangono la morte chi piangono la via
io sono la via di tante tristezze
di uccelli beati che sono dolcenti nelle voce pacate
che nell' aria tormenta si vede parlare
le voce schiarite degli uccelli beati/le voce vedano sui prati
(...)
Il silenzio dell' amore è il silenzio dell' usignolo è una voce pacata
che ristora nel frammento nel vuoto dello spazio
e della via silenziosa
Non mi è stato possibile reperire ulteriori notizie. Per leggere l’articolo di Repubblica clicca qui.
5 mag 2009
Tradimento al mulino
"Si narra di un giovane mugnaio che, invaghitosi di una bella e giovane contadinotta, cliente un giorno del suo mulino, le mise gli occhi addosso e, una volta accortosi della sua “disponibilità”, decise…di farle la festa. Con vari pretesti ritardò la molitura del grano, aspettando che arrivassero, complici, le prime ombre della sera. La bella donna partì finalmente con il suo asino carico di profumata farina verso il vicino territorio di Guardia dei Lombardi, sperando in cuor suo che il focoso e ardimentoso giovane “mulinaro”, che non le era certo indifferente, osasse di più e la raggiungesse strada facendo: così fu. Mentre l’asino, col suo prezioso carico, attendeva paziente e tranquillo legato ad un olmo brucando l’erba, i due si “ infrattarono” al chiaro di luna, accompagnati da mille lucciole; la bella e procace campagnola, “ianca e rossa cum’ a na c’rasa”, sebbene regolarmente e felicemente sposata, concesse ben volentieri le sue grazie al giovane mugnaio: i grilli lanciavano i loro cri-cri d’amore ed il malinconico chiuuuu…di un assiolo si perdeva lontano, nella notte serena…In seguito però i parenti di lei lo vennero a sapere ed il marito giurò tremenda vendetta. La cosa però non gli riuscì: il giovane “cornificatore” andava frequentemente a ballare, come tanti ragazzi di Carife, nelle masserie di Guardia dei Lombardi, dove non mancavano certo le belle ragazze, che spesso finivano per sposare proprio un Carifano. Una sera, consapevole dei rischi che correva (le minacce infatti erano già arrivate alle sue orecchie), si presentò al ballo in buona compagnia e uno dei suoi amici aveva addirittura un fucile.Il marito di lei alla fine, “cornuto e mazziato”, dovette sottostare anche agli scherzi che l’allegra compagnia gli riservò durante tutta la serata trascorsa tra “tarantelle” e “batticuli”, cosa nella quale le ragazzone “guardiole” erano incontrastate ed esperte maestre: ci si ritirava a notte fonda a casa con il “lato B” pieno di lividi, causati dalle micidiali e ben assestate “culate” e “ancate”delle ragazze, che fin da piccole apprendevano quest’arte dalle loro mamme e dalle loro nonne".
24 apr 2009
Il contadino "cafone"

Secondo l’enciclopedia libera Vikipedia: “l'origine del termine è incerta; molti dizionari (come lo Zingarelli) la danno per sconosciuta.
- È però popolare la seguente interpretazione: nell'entroterra del basso Lazio, ai confini con la Campania, intorno al 1400, quando nei comuni del Frusinate o del Casertano arrivavano gli abitanti dei villaggi montani delle zone adiacenti, con delle funi arrotolate intorno alla spalla o alla vita, per acquistare il bestiame nelle fiere, questi venivano identificati dagli abitanti locali come quelli co' 'a fune. Da qui, il termine.
- Quest'interpretazione non gode di credito presso gli studiosi di etimologia, che danno come più probabile una derivazione dal latino 'cabònem (da cabo-onis, "cavallo castrato") oppure dal nome di un centurione romano di nome Cafo.
- Due anni dopo la morte di Cesare (15 marzo 44 a.C.), venne dedotta in Benevento (42 a.C.) una colonia di veterani che aveva combattuto col dittatore un po' dovunque, dalla Gallia, alla Bretagna, nella Spagna, in Gracia ed in Egitto. La deduzione fu voluta da Antonio collega del consolato di Cesare ed ora rivale del suo erede Ottaviano e fu guidata da Lucio Munazio Planco che si orientò verso Ottaviano quando gli eventi si volsero propizi a quest'ultimo.Fra gli invitati a distribuire i nuovi lotti nell' agro pubblico del Sannio e della Campania, operò un rozzo centurione di nome Cafo che si insediò con i suoi nel territorio di Capua dove prese a spadroneggiare. E dovettero essi apparire rozzi e villani a quei campani che conservavano la luce di una vetusta civiltà ed il culto per l'eloquenza, la poesia, la musica ed il canto "Cafones" furono i seguaci di Cafo ed il nome penetrato nell'uso popolare si diffuse nelle altre città del Mezzogiorno dove è adoperato per indicare persone poco use alla vita cittadina, ma soprattutto di modi inurbani e rozzi”.
L’attribuzione di un significato offensivo al termine si ha a partire dall’unità d’Italia, ad opera dei piemontesi che definiscono cafoni in senso dispregiativo i contadini, i braccianti ed i pastori del Sud poiché si trovano in una condizione sociale ed economica assai diversa rispetto a quella in cui si trovano a vivere gli abitanti del Nord. Da allora, il termine cafone ha perso il significato nobile originario di “contadino” e di “persona di condizione umile” ed ha assunto quello di “persona spregevole, ignorante e maleducata”.
Condivido pienamente quanto scritto, più di mezzo secolo fa, da Ignazio Silone nel libro Fontamara: “io so bene che il nome di cafone, nel linguaggio corrente del mio paese, sia della campagna che della città, è ora termine di offesa e dileggio; ma io l'adopero in questo libro nella certezza che quando nel mio paese il dolore non sarà più vergogna, esso diventerà nome di rispetto, e forse anche di onore".
21 apr 2009
Guardiese condannato a morte per l'omicidio di un compaesano
Non è saputo se la condanna sia stata eseguita e nell'articolo si avanza l'ipotesi che "possa essere proprio lui quel Francesco Giallanella, brigante della banda Schiavone, che bruciò la masseria di un liberale di Guardia nel 1862, (...) che la fece in qualche modo franca".
14 apr 2009
Insorgente guardiese fucilato a San Severo

Il libro di Giovanni Saitto, La Capitanata fra briganti e piemontesi, riporta l'elenco di oltre cinquecento insorgenti (briganti secondo l'agiografia risorgimentale) fucilati o catturati a Capitanata (Puglia) ad opera dei piemontesi.
Nell'elenco compare Esposito Matteo, nato a Guardia Lombardi e fucilato a San Severo il 13 febbraio 1863.
Oltre alle generalità, al luogo di nascita e di fucilazione non mi è stato possibile, per ora, reperire ulteriori notizie.
6 apr 2009
Padrone e sotto: un "torneo di oratoria contadina"

Negli anni passati, quando la vita dei contadini era molto dura e misera, il "padrone e sotto" rappresentava una delle poche occasioni per dimenticare i guai, le amarezze, le sofferenze, le ingiustizie e le fatiche della vita, e per ubriacarsi a spese altrui. Molto spesso, quando l'alcol iniziava ad annebbiare le menti, nel gioco venivano proiettate ostilità, invidie e rancori tra i giocatori e si finiva, inevitabilmente, con lo scatenare liti furibonde.
Carlo Levi, nel libro Cristo di è fermato a Eboli ambientato in Lucania durante glia anni '35-'36, scrive: "La passatella è il gioco più comune quaggiù è il gioco dei contadini. Nei giorni di festa, nelle lunghe sere d’inverno, essi si trovano nelle grotte del vino, a giocarla. Ma spesso finisce male; se non sempre a coltellate come quel giorno, in litigi e baruffe. La passatella, più che un gioco, è un torneo di oratoria contadina, dove si sfogano, in interminabili giri di parole, tutti i rancori, gli odi, le rivendicazioni represse. Con una partita breve di carte si determina un vincitore, che è il Re della passatella, e un suo aiutante. Il Re è il padrone della bottiglia, che tutti hanno pagato; e riempie i bicchieri a questo e a quello, secondo il suo arbitrio, lasciando a bocca asciutta chi gli pare, l’aiutante offre i bicchieri, e ha diritto di veto: può cioè impedire a chi si appresta a bere di portare il bicchiere alle labbra. Sia il Re che l’aiutante debbono giustificare il loro volere e il loro veto, e lo fanno, in contraddittorio, con lunghi discorsi, dove si alternano l’ironia e le passioni represse. Qualche volta il gioco è innocente e si limita allo scherzo di far bere tutto a uno solo, che sopporta male il vino, o di lasciare a secco proprio quello che si sa amarlo di più. Ma il più delle volte, nelle ragioni adottate dal Re e dall’aiutante, si rivelano gli odi e gli interessi, espressi con la lentezza, l’astuzia, la diffidenza e la profonda convinzione dei contadini. Le passatelle e le bottiglie si seguono una all’altra, per delle ore, finché i visi sono accesi per il vino, per il caldo, e per il destarsi delle passioni, aguzzate dall’ironia e appesantite dall’ubriachezza. Se ancora non scoppia la lite, è in tutti l’amarezza delle cose dette, degli affronti subiti”.
La passatella dei contadini lucani descritta da Levi è la passatella dei contadini di ogni paesino meridionale di quegli anni, accomunati dalla medesima condizione di povertà.
Ancora oggi a Guardia Lombardi il "padrone e sotto" è un gioco praticato nei bar, forse come semplice passatempo, con i giocatori seduti ai tavolini ed un contorno di spettatori a godersi lo spettacolo.
26 mar 2009
Cenni sul brigantaggio meridionale

Nel 1860 Garibaldi sconfisse il regime borbonico e unificò l'Italia sotto la bianca croce dei Savoia. Il Meridione, quindi, fu annesso agli altri Stati dominati da Casa Savoia, ma, rispetto a questi, presentava una profonda arretratezza ed un grande squilibrio sociale. La grande massa dei braccianti agricoli era ridotta alla fame. La ricchezza era, infatti, iniquamente distribuita fra un ristretto numero di latifondisti e la massa dei braccianti.
Con la proclamazione del Regno d’Italia, nel marzo del 1861, i contadini del Sud avevano sperato in una riforma agraria che prevedesse l'assegnazione di terre da coltivare. L’impresa di Garibaldi, infatti, era accompagnata da una leggenda che annunciava terra per i “cafoni” (così venivano definiti all’epoca i braccianti ed i contadini), cosa che non si verificò. Anzi, lo Stato dell'Italia unificata peggiorò ancora di più le condizioni di vita dei contadini del Sud, introducendo pesanti tasse e trascurando le problematiche economiche e sociali del Mezzogiorno.
Le pessime condizioni di vita ed una forte propaganda dei nostalgici dei borboni, volta ad incitare le masse dei disagiati a contrastare i conquistatori piemontesi, diedero vita ad un violento fenomeno di guerriglia che si diffuse prevalentemente in Campania, Basilicata ed Abruzzo, definito brigantaggio meridionale.
Il brigantaggio fu, principalmente, la ribellione dei pastori e dei braccianti senza terra defraudati dal nuovo ordine sociale, la risposta violenta al profondo disagio socio-economico vissuto negli anni dell’unità d’Italia, alle continue ingiustizie subite nel corso dei secoli ad opera dei ricchi padroni, anche se il fenomeno fu liquidato, dai piemontesi e dagli unitari, come una vera e propria manifestazione di banditismo, posta in essere da ladri, delinquenti, criminali e raziatori, istigati e diretti dai fedeli del re in esilio.
Antonio Gramsci scrisse "Lo Stato italiano (intendendo lo Stato sabaudo) è stato una dittatura feroce che ha messo a ferro e fuoco l'Italia meridionale e le isole, squartando, fucilando, seppellendo vivi i contadini poveri che scrittori salariati tentarono di infamare col marchio di briganti".
Con l’unificazione dell’Italia i contadini venivano nuovamente esclusi dal processo di trasformazione della proprietà fondiaria ed allarmati dai nuovi assetti proprietari, in cui le terre passavano dalle mani dei vecchi feudatari a quelle dei nuovi proprietari nobili e borghesi.
Carlo Dotto de Dauli nel 1877 scriveva "Il brigante è, nella maggior parte dei casi, un povero agricoltore e pastore di tempra meno fiacca e servile degli altri che si ribella alle ingiustizie e ai soprusi dei potenti e, perduta ogni fiducia nella giustizia dello Stato, si getta alla campagna e cimenta la vita, anelando vendicarsi della società che lo ridusse a quell'estremo".
Dal 1861 in poi, il brigantaggio assunse dimensioni dilaganti, obbligando lo Stato piemontese ad impiegare un consistente numero di soldati nel Sud. Si scatenò una vera e propria lotta armata tra briganti e soldati, una guerra civile che fece un'ecatombe di vittime, nelle campagne la vita scorreva in un inaudito livello di violenza.
Venivano incendiati municipi e uffici del catasto, che il brigante Crocco definiva "gli eterni nemici nostri"; saccheggiate le case dei "galantuomini" usurpatori di terre demaniali; distrutti stemmi sabaudi ed immagini del nuovo Re Vittorio Emanuele e di Garibaldi; issati gli stemmi borbonici; insediate nuove amministrazioni comunali filo borboniche.
La legge Pica del 15 agosto 1863 introdusse misure eccezionali per sopprimere il fenomeno: le zone maggiormente infestate dal brigantaggo furono assoggettate alla giurisdizione militatre e vennero effettuati rastrellamenti e fucilazioni di briganti.
L’azione dei briganti diventava sempre più violenta, riscuotendo sempre meno consenso presso la povera gente, che inizialmente si era mostrata estremamente solidale. I capibanda furono, nel giro di pochissimo tempo, tutti catturati, altri si consegnarono spontaneamente alle autorità piemontesi per ottenere uno sconto di pena.
Il brigante Crocco nella sua autobiografia scritta nel corso degli anni di carcere afferma: “la reazione fu il frutto dell’ignoranza, ciò sarà vero, anzi, verissimo, ma a promuovere le reazioni vi concorsero pure questi arrabbiati signorotti di provincia, i quali con sfacciata millanteria dicevano ‘è venuto il nostro tempo’. E i poveri oltraggiosi risposero: ‘è venuto pure il nostro tempo’”.
Questa "sciagurata e ingloriosa" guerra, come la definì Aurelio Saffi, non favorì quella giustizia sociale tanto invocata dai contadini e pagata col prezzo del sangue. Ad essi non restò che la scelta "brigante o emigrante"; ed ebbe inizio un'altra (triste) pagina della Storia del Meridione: l'emigrazione.
24 feb 2009
Le testimonianze dei vinti

Fui molto colpito dall’introduzione, che stimolò in me il desiderio di approfondire il passato del mio paese. Soprattutto di quella parte del paese che molto spesso non viene ricordata nei libri, di quella parte anonima e silenziosa che è stata per secoli il caposaldo della nostra comunità.
Così scrive l’autore: “altro elemento importante e fondamentale della nostra società è costituito dalle testimonianze dell’antica civiltà contadina, che andrebbe adeguatamente indagata e valorizzata, facendo conoscere la vecchia struttura agraria con le antiche masserie, i prodotti della terra, l’alimentazione frugale delle generazioni passate, povera ma genuina, i tradizionali lavori agricoli, i costumi, le usanze, i riti propiziatori e la religiosità (…)
Vogliamo dire ai giovani, soprattutto ai giovani della campagna, di essere sempre fieri ed orgogliosi delle loro origini contadine, tenendo presente che la nostra è stata ed è tuttora prevalentemente una comunità socialmente ed economicamente contadina. In loro, più fortunati dei propri avi analfabeti e culturalmente dipendenti da pochi “scolasticamente più dotati”, vogliamo stimolare una consapevole presa di coscienza e il desiderio di conoscenza e approfondimento delle nostre popolazioni, delle piccole-grandi cose che hanno fatto, di ricercare e valorizzare il nostro passato, quale antidoto ad una certa indifferenza, ad una certa disintegrazione delle coscienze provocata dalla civiltà dei consumi e, nelle nostre zone, anche da alcuni perversi effetti finanziari del terremoto (…)
La presente pubblicazione vuole essere anche un omaggio e un meritato e doveroso riconoscimento a tanti nostri concittadini, che per secoli hanno vissuto in queste contrade accompagnati da duro e faticoso lavoro eppure, quando costretti ad emigrare, hanno portato con sé non solo le loro doti di laboriosità ed ingegno ma anche una insopprimibile nostalgia per il luogo di origine (…)
Molti dei nostri emigrati, soprattutto quelli di prima e seconda generazione, non hanno smarrito il senso profondo della loro appartenenza ad una comunità e ad una cultura contadina e quindi delle proprie radici".
"La cultura italiana - scrive Rocco Scotellaro - sconosce la storia autonoma dei contadini, il loro più intimo comportamento culturale e religioso, colto nel suo formarsi e modificarsi presso il singolo protagonista. Chi volesse, pertanto, assumere il singolo contadino come protagonista della sua storia, dovrebbe impostare la ricerca secondo la via più diretta dell'intervista e del racconto autobiografico".
Uno degli obiettivi di questo sito consiste nel raccogliere le testimonianze delle persone di Guardia Lombardi, soprattutto di quelle più anziane. Esse, infatti, rappresentano la memoria storica del paese, la testimonianza di ciò che il paese è stato.
Nuto Revelli, nel libro "Il mondo dei vinti", scrive: "i miei interlocutori più validi sono i vecchi, perchè sanno. I vecchi sono narratori e attori straordinari. Accettano sempre il dialogo, hanno fame di parlare. Quando li incontro per caso mi parlano del vento e della pioggia, della campagna che va a perdere, della miseria antica che era ugualglianza. Con la nostalgia dei vent'anni mi dicono: nella miseria la gente era allegra, cantava. Una fetta di polenta, una manciata di castagne, e venivano su come querce, il lavoro non spaventava
Secondo me i libri di Revelli "Il mondo dei vinti" e "L'anello forte" ed i suggerimenti di Scotellaro sono la strada da seguire. Occorre raccogliere le testimonianze degli anziani e trascriverle così come sono raccontate senza distorcerle. Occorre salvare le espressioni dialettali più significative. Occorre riscrivere un'altra storia, quella dei vinti.
19 feb 2009
Francesco De Sanctis ringrazia i guardiesi
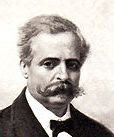
Nel 1863 partecipò come candidato alle elezioni suppletive, ottenendo il consenso unanime dei cittadini di Guardia Lombardi. A Morra Irpina, invece, ottenne solamente 46 voti voti, pochi rispetto ai 140 del rivale Girolamo Del Balzo.
Per ringraziare i cittadini guardiesi della fiducia e della stima manifestategli, scisse una lettera ed un telegramma all'allora sindaco Francesco Fischetti.
Ecco di seguito i testi della lettera e del telegramma:
Il vostro concittadino vi ringrazia
del nobile indirizzo, che conserverà come
cara memoria, e fa caldi auguri di prosperità
alla sua seconda patria, che verrà a visitare dopo l'elezione.
Ricevuto 8-1-1883 ore 18:45
da S. Giordio a Cremano n. 15 parole 29 8 gennaio ore 16:15
Prego trasmettere telegramma seguente Sindaco Guardia Lombardi
Di Guardia mi rimarrà cara, eterna memoria. Votazione unanime
ha lavate molte vergogne circonvicine contrade native.
Il giorno successivo alle elezioni, De Sanctis ringrazia i guardiesi per la "votazione unanime" ed esprime la delusione per lo scarso risultato ottenuto nel proprio paese natio.
3 feb 2009
I soldi del viaggio per emigrare in America

Verso la fine del 1800, Guardia Lombardi, piccolo paese irpino situato a circa
La principale fonte di sostentamento era rappresentata dall’agricoltura, però troppo frazionata e con un livello tecnologico e produttivo insufficiente a garantire una vita dignitosa alla maggior parte delle famiglie che abitavano il paese. La completa assenza di pastorizia aggravava ancora di più la situazione, mettendo a rischio molto spesso la sussistenza di intere famiglie.
L’unica speranza, per questi contadini, di migliorare la propria esistenza era forse rappresentata dall’emigrazione, dal mito delle Americhe. Ed è proprio in questi anni che gli espatri raggiungono i picchi più elevati.
Non poche erano le difficoltà da superare prima di partire: la paura di approdare in una terra sconosciuta, la nostalgia del paese d’origine, il dolore del distacco dalla propria famiglia. Ma le disperate condizioni di vita, la voglia di riscatto e la fame inducevano coraggio.
Superate le difficoltà psicologiche, rimaneva pur sempre l’aspetto economico da risolvere: le spese del viaggio. Occorrevano all’incirca 300 lire ma quasi nessuno disponeva di tale somma. Allora le soluzioni erano due: la “vendita con patto di ricompra” ed il “prestito ad interesse annuo”.
Con la prima, il debitore/emigrante cedeva temporaneamente un pezzo di terra al finanziatore/creditore (spesso rappresentato dal proprietario terriero più benestante), il quale ne poteva disporre a proprio piacimento. Alla scadenza fissata, se il debitore fosse risultato insolvente, cioè se non avesse riscattato il terreno al prezzo pattuito, il creditore avrebbe acquisito la proprietà del terreno. Formalmente, il prezzo di riscatto pattuito era pari al valore di mercato del terreno, mentre gli interessi erano corrisposti sotto forma di libero utilizzo del terreno stesso.
La seconda soluzione, invece, consisteva in un vero e proprio prestito di denaro con corresponsione di interessi monetari.
Con la “vendita” il finanziatore aveva come garanzia il terreno (e spesso il prezzo di riscatto pattuito era superiore al prezzo di mercato del terreno), mentre, il “prestito” poteva indurre il debitore all’insolvenza, qualora fosse emigrato definitivamente e non avesse lasciato familiari in paese.
Nella maggior parte dei casi i debiti sono stati onorati e gli emigranti hanno inviato ulteriore denaro a Guardia Lombardi, affinché le proprie famiglie potessero vivere in una vera e propria casa e comprare terreni sufficienti per condurre una vita dignitosa. Con la speranza, un giorno, di ritornare laddove erano nati, laddove avevano lasciato il loro cuore e la loro anima.
Molte delle informazioni riportate nell’articolo sono contenute nel libro di A. Arru, F. Ramella, L’Italia delle migrazioni interne. Donne, uomini, mobilità in età moderna e contemporanea. Donzelli editore, p. 292 e ss.